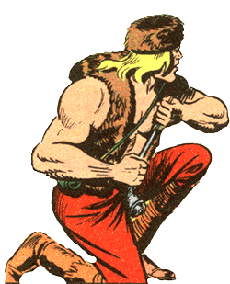
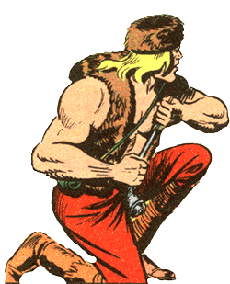

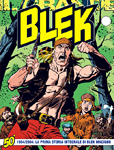 Tra
la fine della guerra e i primi segni del boom economico,
l’America cambia volto. Per i ragazzini italiani degli
anni Cinquanta, i marines e il D-Day sono poco più che
un ricordo lontano: per loro, l’America è già quella di
«Gunga Din e Ringo», come Francesco Guccini avrebbe cantato
qualche decennio più tardi. L’America è un berretto alla
Davy Crockett, un gilet di pelo sul torso nudo, un paio
di calzoni rossi tenuti fermi da una striscia di cuoio.
Nel 1954, per chi ha ancora la voglia e l’età per sognare,
l’America è il vecchio West inventato da disegnatori che
non hanno mai visto da vicino un canyon o un bisonte;
è la carta povera dei fumetti: sottili, stampati alla
meglio, spesso senza colori. Ma letti come non mai, passati
di mano in mano, venduti a milioni. «Nella immensa foresta
di abeti un gigante dai lunghi capelli biondi è intento
a preparare trappole per le volpi». E’ questa didascalia,
il 3 ottobre di mezzo secolo fa, a introdurre le avventure
di un nuovo personaggio: il Grande
Blek, scritto così, all’italiana,
con quella kappa finale ad aggiungere quel tocco di naïvité
esotica che non guasta quando si deve raccontare di terre
e tempi lontani. Gli autori sono Giovanni Sinchetto, Dario
Guzzon e Pietro Sartoris, un trio torinese che da qualche
anno teneva la ribalta con le storie di «Capitan Miki»,
il più fortunato tra gli eroi bambini che in quegli anni
dominavano le edicole: adolescenti che passavano da un’avventura
all’altra, senza scuola né genitori, fabbri della loro
propria fortuna. Tra
la fine della guerra e i primi segni del boom economico,
l’America cambia volto. Per i ragazzini italiani degli
anni Cinquanta, i marines e il D-Day sono poco più che
un ricordo lontano: per loro, l’America è già quella di
«Gunga Din e Ringo», come Francesco Guccini avrebbe cantato
qualche decennio più tardi. L’America è un berretto alla
Davy Crockett, un gilet di pelo sul torso nudo, un paio
di calzoni rossi tenuti fermi da una striscia di cuoio.
Nel 1954, per chi ha ancora la voglia e l’età per sognare,
l’America è il vecchio West inventato da disegnatori che
non hanno mai visto da vicino un canyon o un bisonte;
è la carta povera dei fumetti: sottili, stampati alla
meglio, spesso senza colori. Ma letti come non mai, passati
di mano in mano, venduti a milioni. «Nella immensa foresta
di abeti un gigante dai lunghi capelli biondi è intento
a preparare trappole per le volpi». E’ questa didascalia,
il 3 ottobre di mezzo secolo fa, a introdurre le avventure
di un nuovo personaggio: il Grande
Blek, scritto così, all’italiana,
con quella kappa finale ad aggiungere quel tocco di naïvité
esotica che non guasta quando si deve raccontare di terre
e tempi lontani. Gli autori sono Giovanni Sinchetto, Dario
Guzzon e Pietro Sartoris, un trio torinese che da qualche
anno teneva la ribalta con le storie di «Capitan Miki»,
il più fortunato tra gli eroi bambini che in quegli anni
dominavano le edicole: adolescenti che passavano da un’avventura
all’altra, senza scuola né genitori, fabbri della loro
propria fortuna. Il Grande Blek è un albo «piccolo», tascabile, stampato nello stesso formato dei primi fumetti western, dal primo Tex Willer in avanti: la «striscia» orizzontale, più economica per gli editori che potevano sfruttare ogni centimetro di carta sulle macchine da stampa in piano, più comoda per i lettori, che potevano nascondere il giornalino nelle tasche, nascondendolo a tutti: agli insegnanti convinti che i fumetti facessero disimparare a leggere, ai parroci e ai catechisti che ammettevano soltanto il Vittorioso creato da Luigi Gedda, l’uomo della propaganda che nel ‘48 aveva sconfitto i comunisti alle prime elezioni del post fascismo. I ragazzi fingevano di ascoltare. Poi, come è sempre successo, leggevano di testa loro. D’altra parte, cinquant’anni fa, le edicole offrivano molto di più. Nella primavera del ‘54 Mondadori aveva lanciato gli Albi del Falco, in cui avrebbe pubblicato i supereroi americani dei Quaranta, con qualche licenza editoriale per risparmiare sui diritti d’autore.  Superman
è «Nembo Kid», Batman il «Pipistrello», con qualche problema
per gli editor italiani, costretti a cancellare la grande
S che Joe Shuster aveva disegnato sul petto del primo
e a ribattezzare «Pipimobile» la macchina che Bob Kane
si era inventato per il secondo. Il Vittorioso alternava
Jacovitti e Procopio a tavole d’avventura religiosamente
corrette. L’Intrepido raccontava di pirati, principi e
cavalieri. Topolino usciva dal ‘49 con lo stesso formato
e gli stessi protagonisti di oggi. Su tutto, però, si
ergeva il West. Nel ‘54, indiani e cowboy «erano» l’America.
«Hollywood produceva film western a decine», ricorda Sergio
Bonelli, l’editore di Tex, l’unico eroe della frontiera
sopravvissuto all’invasione di mutanti, robot e tipi strani.
«La tv, che negli Stati Uniti aveva già messo radici,
presentava decine di serial a base di pistole e cavalli:
Bonanza, Rawhide, Gun Law, Wagon Train…». Superman
è «Nembo Kid», Batman il «Pipistrello», con qualche problema
per gli editor italiani, costretti a cancellare la grande
S che Joe Shuster aveva disegnato sul petto del primo
e a ribattezzare «Pipimobile» la macchina che Bob Kane
si era inventato per il secondo. Il Vittorioso alternava
Jacovitti e Procopio a tavole d’avventura religiosamente
corrette. L’Intrepido raccontava di pirati, principi e
cavalieri. Topolino usciva dal ‘49 con lo stesso formato
e gli stessi protagonisti di oggi. Su tutto, però, si
ergeva il West. Nel ‘54, indiani e cowboy «erano» l’America.
«Hollywood produceva film western a decine», ricorda Sergio
Bonelli, l’editore di Tex, l’unico eroe della frontiera
sopravvissuto all’invasione di mutanti, robot e tipi strani.
«La tv, che negli Stati Uniti aveva già messo radici,
presentava decine di serial a base di pistole e cavalli:
Bonanza, Rawhide, Gun Law, Wagon Train…».  E’
quasi ovvio che quella passione si trasmettesse ai fumettisti
italiani, che pure non conoscevano la storia americana,
né avevano troppe occasioni per impararla: «Libri in italiano
non ce n’erano - continua Bonelli - . E ancor meno esisteva
una documentazione fotografica: inutile negare che quei
fumetti proponessero un Far West improbabile: i canyon
e i rilievi in cui si muoveva il primo Tex, per esempio,
erano più vicini alle Dolomiti o alla Sardegna piuttosto
che alle Rocky Mountains, fantastiche e lontane». Il Grande
Blek non si discosta dal modello della fantasia autarchica:
anche per Sartoris,
Guzzon e Sinchetto la favola
ha una funzione preminente rispetto alla Storia; i caratteri
sono a tutto tondo, evidenti fin dall’aspetto fisico dei
personaggi: i buoni, a partire da Blek, sono tutti bellissimi;
i cattivi, a cominciare da Harold, l’infame traditore
del primo episodio, sono orrendi, sporchi, spesso addirittura
deformi. E’
quasi ovvio che quella passione si trasmettesse ai fumettisti
italiani, che pure non conoscevano la storia americana,
né avevano troppe occasioni per impararla: «Libri in italiano
non ce n’erano - continua Bonelli - . E ancor meno esisteva
una documentazione fotografica: inutile negare che quei
fumetti proponessero un Far West improbabile: i canyon
e i rilievi in cui si muoveva il primo Tex, per esempio,
erano più vicini alle Dolomiti o alla Sardegna piuttosto
che alle Rocky Mountains, fantastiche e lontane». Il Grande
Blek non si discosta dal modello della fantasia autarchica:
anche per Sartoris,
Guzzon e Sinchetto la favola
ha una funzione preminente rispetto alla Storia; i caratteri
sono a tutto tondo, evidenti fin dall’aspetto fisico dei
personaggi: i buoni, a partire da Blek, sono tutti bellissimi;
i cattivi, a cominciare da Harold, l’infame traditore
del primo episodio, sono orrendi, sporchi, spesso addirittura
deformi. Vicino a Blek c’è Roddy, il piccolo orfano, condizione fin troppo comune tra i lettori figli della guerra. Sullo sfondo il dottor Occultis, l’altrettanto immancabile spalla comica. La novità è nella scelta del Tempo. Il western, più o meno, si colloca tutto tra il conflitto con il Messico del 1846 e il massacro di Wounded Knee del 1890. Blek viene prima, molto prima: siamo nel Maine, il grande Nord dell’America, negli anni Settanta del Settecento, nel pieno della guerra d’indipendenza. Niente ranger del Texas, niente fortini assediati dagli Apaches, niente ranch di bovari, ma la lotta fra i Trappers, i cacciatori dei boschi, e le Giubbe Rosse della corona inglese. Uno sfondo sul quale si innestano i topoi della fantasia fumettistica: mostri e giganti, maghi e pirati; personaggi di ogni tipo tratti da ogni possibile fonte di ispirazione: il teatro, la letteratura popolare, il cinema, persino la piccola, nascente televisione. Gli stereotipi sono in agguato: gli ebrei hanno il naso adunco, i neri sono simpatici selvaggi, i nemici inglesi sono rozzi, ignoranti e violenti. Molti ridono, nessuno si lamenta. «D’altra parte - racconterà Guzzon qualche mese prima di morire - non è che nell'Italia settentrionale di allora gli inglesi bombardatori fossero ricordati con troppo affetto». Il fumetto, allora, era questo, modellato sui suoi lettori: semplice ma non sciatto, con qualche insospettabile elemento di modernità. Come l'idea del cacciatore ecologista impersonata da Blek e dai suoi amici trapper: «Che strani esseri sono gli uomini - dice il protagonista nel primo episodio, esattamente mezzo secolo fa -. Vogliono conquistare tutta la terra e il cielo, e poi dormono su letti alti otto piedi per non toccare la terra, e si chiudono in quelle scatole chiamate palazzi per non vedere più il cielo…». |